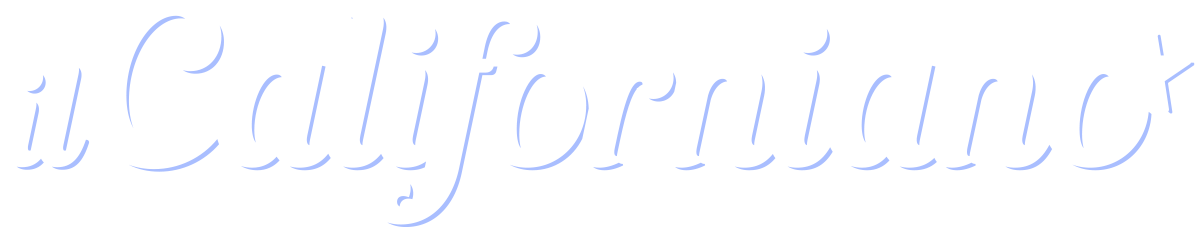Oggi ricorrono ventiquattro anni dagli attentati dell’11 settembre 2001, quando quattro aerei di linea vennero dirottati da un commando di al Qaida, organizzazione terroristica islamista di origine afghana attiva dal 1988, e lanciati contro obiettivi simbolici negli Stati Uniti. Le immagini delle Torri Gemelle che crollano a Manhattan sono rimaste fissate nella memoria collettiva, ma ogni anniversario offre l’occasione di una rilettura dell’evento attraverso altre prospettive, permettendo di comprendere le profonde conseguenze di quel giorno.
Il World Trade Center, inaugurato all’inizio degli anni Settanta, era il centro direzionale della Grande Mela, simbolo della modernità economica e della fiducia americana nell’architettura come rappresentazione di potere. I due grattacieli, progettati da Minoru Yamasaki, all’epoca erano i più alti del mondo e avevano contribuito a ridisegnare la skyline di New York. Quando furono abbattuti, con loro crollò letteralmente un’idea di invulnerabilità che aveva accompagnato l’Occidente per gran parte della seconda metà del Novecento.
Le torri gemelle in una foto dello skyline di New York nel 1995 | via Shutterstock
L’attacco non colpì soltanto New York. Un altro aereo fu fatto schiantare contro il Pentagono, quartier generale del Dipartimento della Difesa a Washington, mentre il quarto, diretto probabilmente verso il Congresso o la Casa Bianca, precipitò in Pennsylvania grazie alla rivolta dei passeggeri. L’azione coordinata in quattro punti diversi del Paese aveva come obiettivo dimostrare che gli Stati Uniti potevano essere raggiunti e violati in un modo mai immaginato prima.
Gli effetti politici e sociali furono immediati. Il presidente George W. Bush dichiarò la “guerra al terrorismo” e pochi mesi dopo gli Stati Uniti invasero l’Afghanistan, accusato di ospitare i vertici di al Qaida. Nel 2003 la campagna militare si estese anche all’Iraq, in un intreccio di motivazioni e giustificazioni che avrebbero segnato la politica internazionale per decenni. Nella vita quotidiana degli americani, invece, gli attentati cambiarono radicalmente i protocolli di sicurezza, dalle procedure negli aeroporti alla sorveglianza elettronica interna.
Giornalisti e pompieri vicino al Ground Zero poco dopo il crollo delle torri | via Shutterstock
Il modo in cui New York ha elaborato il trauma ha seguito percorsi complessi. L’area di Ground Zero, per anni spazio aperto e dolorosamente vuoto, è diventata progressivamente un luogo di ricostruzione simbolica. Oggi al suo posto si trovano il Memoriale e il Museo dell’11 settembre, con le due vasche che ripercorrono l’ingombro delle Torri e i nomi delle quasi tremila vittime incisi nel bronzo. La ricostruzione urbanistica ha incluso anche il grattacielo One World Trade Center, inaugurato nel 2014, alto 541 metri (1776 in piedi, altezza scelta per rappresentare l’anno della dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti), progettato per restituire una nuova centralità alla zona sud di Manhattan.
Un altro aspetto meno visibile riguarda la trasformazione culturale. Dopo l’11 settembre la città ha visto nascere un numero crescente di iniziative artistiche e di memoria collettiva: spettacoli teatrali, film, romanzi e opere d’arte hanno cercato di elaborare non solo la tragedia, ma il senso di perdita e di cambiamento che essa aveva provocato. In questo modo il trauma è stato integrato nella politica, nell’urbanistica e nel racconto quotidiano della cultura americana e internazionale.
Ventiquattro anni dopo, l’11 settembre continua a essere un punto di riferimento. Non soltanto per chi visse quei momenti davanti agli schermi televisivi, ma anche per generazioni più giovani che non hanno un ricordo diretto dell’evento e lo conoscono soltanto come fatto storico. Ogni anniversario riporta la città e il Paese a confrontarsi con ciò che quell’attacco rappresentò: il momento in cui la percezione di sicurezza fu irrimediabilmente trasformata.
L’articolo Gli Stati Uniti ventiquattro anni dopo proviene da IlNewyorkese.